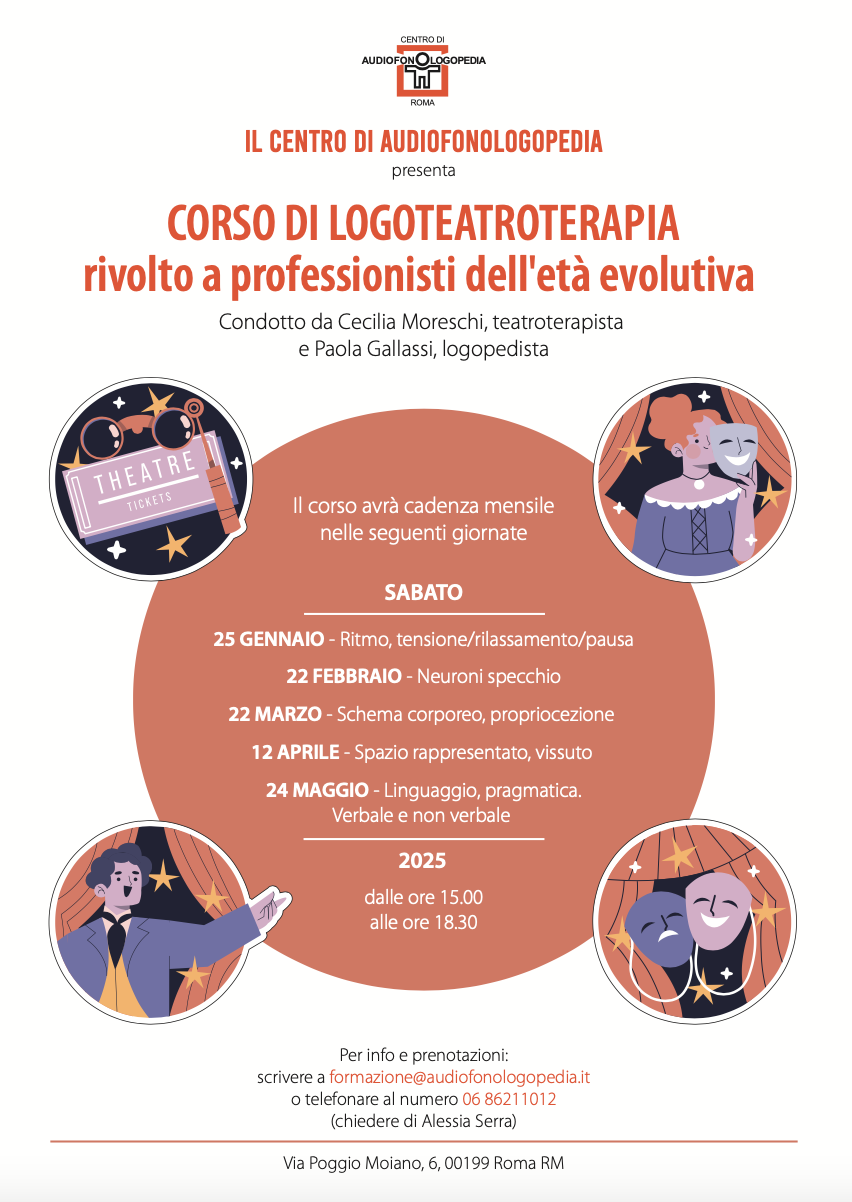Numerosi attori, registi e drammaturghi (nonché insegnanti, educatori, psicologi e varie altre figure professionali) di diverse epoche storiche hanno sottolineato l’importanza del laboratorio teatrale all’interno degli istituti scolastici affinché fosse alla portata delle giovani generazioni. Dal migliorare l’apprendimento di materie quali letteratura, storia, scienze o filosofia, al potenziare le abilità dialogiche, il public speaking e la corretta dizione; dall’ampliare il lessico e la pragmatica, all’allungare i tempi di attenzione e il bagaglio mnemonico, possiamo davvero dirci tutti d’accordo nell’affermare che l’arte scenica sia uno strumento sopraffino per lavorare su tutto questo e tanto altro ancora.
Negli ultimi anni inoltre, dati spiacevolissimi fatti di cronaca, si è spesso affrontato l’argomento della mancanza di empatia presente (a volte) nell’adolescenza. Di conseguenza, nel riflettere sul ben doloroso fenomeno, eminenti psicologi, educatori, medici e terapisti si sono trovati ulteriormente d’accordo nell’affermare che nulla quanto il teatro stimoli l’attore o attrice a “mettersi nei panni dell’altro” dovendo giocoforza interpretare personaggi sempre differenti dalla propria realtà.
Eppure, le immense possibilità del Teatro Ragazzi non si fermano qui.
Uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi, il premio Nobel per la letteratura nel 1934 Luigi Pirandello, era solito scrivere le sue commedie scena per scena, nella solitudine del proprio studio. La sera si recava alle prove della compagnia e assisteva al modo in cui gli attori interpretavano i personaggi che aveva creato. Dalla visione della messinscena modificava il testo, arricchendolo o scremandolo, perché il teatro è qualcosa che vive, che si incarna, e neppure un genio come lui poteva prescindere dall’attore o attrice e da come egli/ella recita la scena. Ma il lavoro non terminava lì. Pirandello era solito affermare che l’ultimo elemento fondante del teatro è il pubblico. Pertanto, nella prima settimana di repliche del nuovo spettacolo, lo scrittore sedeva tra le file degli spettatori, annotando le reazioni di questi ultimi alle varie battute, alle entrate in scena, ai personaggi. E continuava a modificare il suo scritto. Il che ci rimanda ancora una volta all’intima, profondissima connessione che si crea a teatro tra attore e spettatore, tra performance e coloro che vi assistono.
Ecco perché nelle settimane in cui mi trovo a creare una drammaturgia insieme ai ragazzi che la reciteranno, li invito di tanto in tanto a mettersi dal punto di vista dello spettatore. A chiedersi se quel che hanno narrato finora rimanda il messaggio che intendevano; se quel dato personaggio ha mostrato al pubblico la motivazione di quel che fa o che dice; se non hanno dato per scontati elementi importanti o, al contrario, non sono stati ridondanti, ribadendo troppe volte lo stesso concetto, che pertanto potrebbe iniziare ad annoiare chi guarda.
Ecco. Mettersi nei panni dell’altro non è solo interpretare il personaggio. È anche operare una rotazione di 180 gradi e scendere dal palco alla platea. Cambiare punto di vista e indossare per un momento i panni dello spettatore. “Dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse” recitava Robin Williams nei panni del professor Keating, protagonista della splendida pellicola L’attimo fuggente. Anche lui lavorava con degli adolescenti. Ed è memorabile il momento in cui li esorta a salire sulla cattedra e guardare l’aula, la classe da un altro punto di vista. Pure qui c’è una rotazione di 180 gradi e c’è una salita, non una discesa, ma il concetto è lo stesso.
Nel nostro caso, oltre allo scendere in platea, occorre immaginare di non saper nulla della commedia per verificare se le scene realizzate fino a quel momento ne riportano gli elementi desiderati.
Questo continuo esercizio non contribuisce solo alla riuscita della performance. Lavora su aspetti ben più profondi e importanti. Sull’aver sempre presente che la recitazione è un dono per chi vi assiste e come tale dev’essere fruibile. Sull’allenare gli attori a prestazioni, verbali e motorie, sempre più chiare e funzionali. E dati gli studi sulla neuroplasticità del cervello umano (i quali ci rivelano quanto la nostra mente continui a modificarsi anche in età adulta a seconda delle esperienze compiute, e che tali modifiche si riverberano in comportamento) se fatto per un periodo di tempo significativo, tale allenamento potrebbe entrare a far parte della vita di ciascuno, della sua quotidianità. Magari evitando, almeno in parte, il non comprendersi, il non ascoltarsi, il non veicolare con sufficiente chiarezza quel che si intendeva dire. Tutte cause spesso e volentieri, di incomprensioni, litigi, rotture.
Facciamo teatro, dunque. Organizziamo laboratori di Teatro Ragazzi esattamente con questi obiettivi. Facciamo fare teatro alle giovani generazioni e non stimoliamoli solo a mettersi nei panni del personaggio. Anche in quelli dello spettatore.
Cecilia Moreschi
2 febbraio 2025